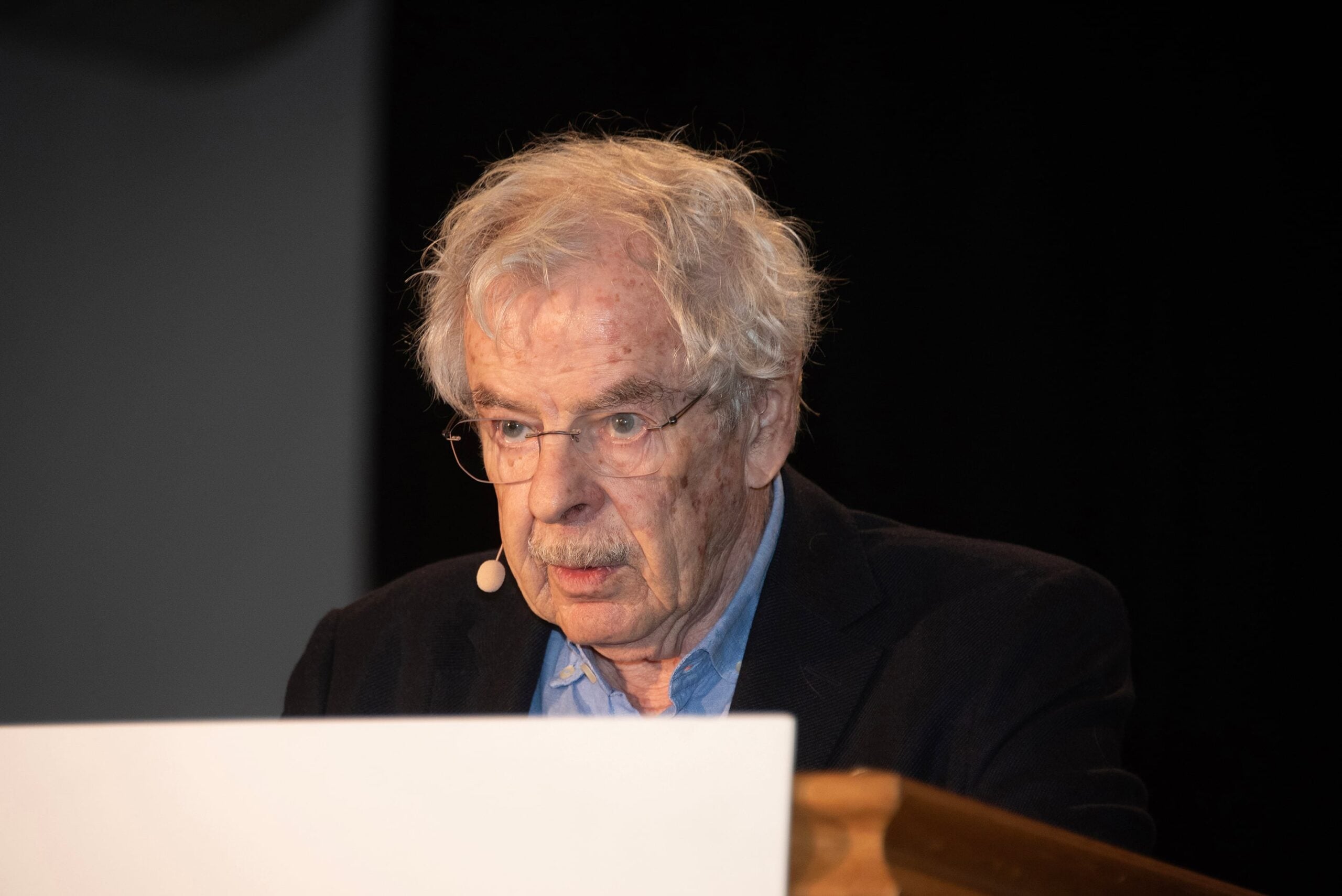Gentili signore e signori,
forse vi stupisce vedere un vecchio esponente della sinistra come oratore alla vostra assemblea riguardo all’iniziativa sulla neutralità. La neutralità è in realtà una questione trasversale ai partiti. O almeno dovrebbe esserlo. Tuttavia, quando l’iniziativa è stata presentata un anno fa, i principali media svizzeri l’hanno immediatamente screditata come «Iniziativa di Putin» o «Iniziativa di Blocher». Questi erano tentativi di denigrare propagandisticamente l’iniziativa fin dall’inizio e, inoltre, un regolamento di conti politico di parte, senza discussione sull’argomento. Come politologo e come cittadino, questo mi ha indignato perché per tutta la vita ho sempre detto ai miei studenti che in Svizzera le questioni nazionali più importanti sono regolate dalla Costituzione. E prima che ciò accada, è l’elettorato ad avere l’ultima parola dopo una discussione seria e orientata ai fatti. Ecco perché oggi mi impegno per l’iniziativa sulla neutralità con motivazioni che dovrebbero convincere non solo i conservatori, ma anche i liberali, la sinistra e i verdi.
Ma veniamo al punto.
Per decenni la neutralità svizzera è stata una cosa talmente ovvia che quasi non se ne parlava. «Siamo un Paese neutrale», questo lo imparava ogni bambino. Ma oggi molti non sanno quasi più cosa significhi. Né i bambini né gli elettori. Anche alcuni membri del Consiglio federale sembrano non capire bene cosa significhi la neutralità. Altrimenti, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nella primavera del 2022, il consigliere federale Cassis non avrebbe potuto adottare parola per parola tutte le sanzioni dell’UE contro la Russia e allo stesso tempo dichiarare che eravamo ancora neutrali. L’estero ha reagito prontamente. Sia il presidente americano Biden che il presidente russo Putin hanno dichiarato con rara unanimità che la Svizzera non era più uno Stato neutrale. Alla conferenza sul Bürgenstock, Selenzky è stato accolto come ospite d’onore, mentre Putin non è stato invitato. E di recente, alcuni militari stanno elaborando seriamente il progetto di un distaccamento svizzero con elicotteri per interventi all’estero. Neutralità, mi chiedo: chi ci crede ancora oggi? Ecco due insegnamenti importanti per noi:
Il primo: non basta se siamo solo noi a credere alla neutralità. La neutralità deve essere soprattutto credibile all’esterno. Questa credibilità, purtroppo, il Consiglio federale l’ha in parte persa negli ultimi tre anni.
Ecco perché l’iniziativa sulla neutralità vuole ora ancorare la neutralità e i suoi principi fondamentali nella Costituzione. Penso che sia una cosa buona e sensata. Infatti, l’iniziativa stabilisce in modo evidente, sia internamente che esternamente, i principali aspetti della nostra neutralità come principio della politica estera. Così facendo, viene in parte sottratta al pensiero a breve termine dei politici e di alcuni consiglieri federali. Ma soprattutto, essa rafforza una politica estera credibile e affidabile. La protegge anche da tentativi di pressione dall’esterno, come quelli che stiamo vivendo proprio ora.
Il secondo insegnamento riguarda la domanda: cos’è la neutralità? Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, non solo i cittadini apolitici, ma anche politici esperti dicevano con voce indignata: «Ma come possiamo rimanere neutrali quando un grande Paese invade un piccolo Paese? Come si può ancora parlare di neutralità quando la Russia commette un crimine internazionale e miete migliaia di vittime tra gli ucraini innocenti?»
L’indignazione era diffusa e non permetteva alcuna discussione. Questo sentimento è umano e comprensibile. Tuttavia, la neutralità non è un atto di simpatia, non è una questione di cuore, ma è il principio di una politica estera. Significa: la Svizzera rimane indipendente, non partecipa alle guerre e contribuisce a risolvere i conflitti violenti in modo pacifico. Il fondamento etico della neutralità è l’idea della pace, non la morale personale. Inoltre, la neutralità serve a preservare l’unità del Popolo internamente. Lo scrittore Carl Spitteler ce lo ha insegnato nel suo discorso «Il nostro punto di vista svizzero» più di 100 anni fa. Allora, allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914, le simpatie degli svizzero-tedeschi erano per l’Impero tedesco, mentre il cuore dei romandi batteva per i francesi. Spitteler fece appello alle parti per mettere da parte queste simpatie unilaterali. Perché se gli svizzero-tedeschi e i romandi avessero seguito la voce del loro cuore, ciò avrebbe portato alla divisione della Svizzera e alla fine della neutralità. E inoltre, una Svizzera divisa avrebbe potuto essere trascinata in guerra. Spitteler fece quindi appello a mantenere un punto di vista indipendente e neutrale.
Quando c’è guerra, il Paese neutrale resta imparziale di fronte alle parti in conflitto. Questo è ciò che la Svizzera ha cercato di fare nella Prima e nella Seconda guerra mondiale, e anche nella guerra fredda – non sempre con successo –, ma è rimasta comunque fedele alla neutralità. Ovviamente abbiamo tutti le nostre simpatie e antipatie personali, ma da un punto di vista politico la Svizzera neutrale non distingue tra Stati «buoni» e «cattivi». L’ex presidente degli Stati Uniti Bush, invece, lo fece con il suo concetto di «asse del male». Secondo lui: «Chi è con noi è uno Stato buono, chi è contro di noi appartiene agli Stati canaglia». Questa ripartizione del mondo in «buoni» e «cattivi» è l’esatto opposto della neutralità.
Anche il Comitato internazionale della Croce Rossa – il CICR – difende l’imparzialità. Perché senza una distanza uguale dalle parti in conflitto – sia dai «buoni» che dai «cattivi» – non potrebbe svolgere i suoi compiti umanitari. Come dimostra il CICR, l’imparzialità non significa indifferenza verso gli eventi mondiali. Perché nonostante la sua neutralità, in campo umanitario la Svizzera ha realizzato cose significative. Questo è iniziato nel 1871 con l’accoglienza degli 80 000 soldati sconfitti dell’esercito Bourbaki nel Giura, con l’accoglienza dei rifugiati di guerra durante le guerre mondiali, dall’Ungheria nel 1965 e ora con i 70 000 profughi dall’Ucraina. L’aiuto umanitario e la ragione di Stato della neutralità non si escludono quindi a vicenda. Questo può essere espresso con una semplice formula: sì alla solidarietà con le vittime di guerra da entrambe le parti, ma no alla solidarietà con una parte in conflitto.
Una questione delicata nella campagna per la votazione sarà il nostro rapporto con la NATO. La situazione geopolitica è incerta. I Paesi europei si stanno armando militarmente, e così anche la Svizzera. Molti pensano che dovremmo metterci sotto lo scudo protettivo della NATO. Io trovo che sia una cattiva idea.
In primo luogo, questo scudo non è gratuito. Come membro della NATO dovremmo sottostare ai doveri legati all’alleanza al posto della neutralità. Gli statuti della NATO prevedono, all’articolo 5, il supporto degli altri Stati membri qualora un Paese si sentisse attaccato. Questo, ovviamente, varrebbe anche per il nostro Paese. Ma non è tutto.
Perché, in secondo luogo, da tempo la NATO non è più una semplice alleanza difensiva. In Afghanistan, Serbia e Libia vi ha condotto guerre o vi è stata coinvolta – talvolta anche contro il diritto internazionale.
La NATO è diventata il braccio militare che, sotto la guida degli Stati Uniti, deve garantire la supremazia dell’Occidente e dei suoi interessi economici. E tutto ciò va ben oltre i confini dell’Europa. «La nostra sicurezza viene difesa non solo, ma anche, sull’Hindukush», disse nel 2004 l’allora ministro della difesa tedesco Peter Struck. Tuttavia, invece di sicurezza e democrazia, questi interventi hanno lasciato un caos politico e un ulteriore flusso di profughi verso l’Europa. Vogliamo davvero permettere che i nostri figli e nipoti partecipino a tali avventure?
«Linder fa l’uccello del malaugurio», diranno i sostenitori della NATO. «Non vogliamo affatto diventare membri, ma semplicemente collaborare con la NATO in questioni tecniche». In un primo momento ciò suona ragionevole e sta già avvenendo, ad esempio nell’aviazione, nella sicurezza aerea e in molti altri settori militari. Ma dove sono i limiti? In manovre congiunte, in stati maggiori congiunti, in contingenti di truppe per la NATO? Dove sono quei limiti: quelle linee rosse che sono inconciliabili con la neutralità? Potremmo trovarci nella stessa situazione come con l’Unione europea: non siamo membri, ma rispettiamo le norme e le aspettative di Bruxelles più fedelmente di alcuni Stati membri dell’UE. E le nostre autorità potrebbero interpretare un’alleanza con la NATO come un ordine di mobilitazione per contingenti svizzeri, invocando la situazione straordinaria e una neutralità «flessibilizzata».
La risposta sincera, però, è: non possiamo avere entrambi, NATO e neutralità. Dobbiamo scegliere, anche se è difficile: NATO o neutralità.
Gli animi sono accesi anche sul tema delle sanzioni. Queste sono misure coercitive unilaterali che uno Stato, un gruppo di Stati o l’ONU adottano contro un altro Stato. Le sanzioni sono sempre più diffuse; alcuni parlano ormai di una vera e propria «sanzionite». Molte di queste sanzioni violano il diritto internazionale e sono misure punitive illecite dei più potenti contro i più deboli. L’iniziativa chiede ora che la Svizzera partecipi solo a quelle sanzioni decise dall’ONU. Il motivo è semplice. Queste sono le uniche sanzioni supportate dall’intera comunità internazionale, a differenza, ad esempio, delle sanzioni dell’UE contro la Russia, che sono controverse in altre parti del mondo. In quanto membro dell’ONU, la Svizzera è tenuta a rispettare le sanzioni non militari ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, adotta misure volte a evitare che vengano aggirate le misure coercitive non militari di altri Stati. Il motivo è che il nostro Paese non dovrebbe esporsi all’accusa di voler trarre profitto dalla guerra.
Cosa pensare al riguardo?
In un primo momento si potrebbe dire che rinunciare alle sanzioni può limitare il margine di manovra nella politica estera. Tuttavia, parlare di una costrizione della politica estera svizzera è assurdo. Infatti, contemporaneamente, rinunciare alle sanzioni amplia le possibilità in campo commerciale. In questo modo, manteniamo intatti i rapporti economici anche con quei Paesi che, ad esempio, non sono d’accordo con le sanzioni statunitensi contro l’Iran. Argomenti ancora più importanti contro le sanzioni sono i seguenti:
- non colpiscono i governi colpevoli, ma il popolo;
- i gruppi più colpiti sono sempre i più poveri;
- la popolazione colpita si solidarizza con il governo sanzionato;
- le sanzioni prolungano il conflitto;
- le sanzioni portano raramente a un cambiamento di regime.
Un esempio? Prendiamo Cuba. Gli Stati Uniti impongono ampie sanzioni contro il regime del piccolo vicino che non gradiscono. Dopo 60 anni, il regime non è stato rovesciato. E nonostante la povertà, non ci sono segnali che la popolazione desideri un altro regime. Il conflitto tra Stati Uniti e Cuba rimane irrisolto, perché non ci sono negoziati per una pace tra le due parti. In altre parole: le sanzioni seguono la logica della guerra, non quella della pace.
L’ultimo punto, ma importante, dell’iniziativa riguarda il tema della pace. La nostra neutralità deve servire esplicitamente, come recita il testo dell’iniziativa, alla conservazione e promozione della pace. La Svizzera è disponibile come mediatrice. Questo è più di un semplice desiderio. La Svizzera ha infatti avviato, organizzato o condotto una serie di attività di mediazione dopo la Seconda guerra mondiale a nome di organizzazioni internazionali. Ne cito alcune:
- La missione svizzero-svedese per la supervisione del cessate il fuoco tra la Corea del Nord e la Corea del Sud (dal 1953)
- L’organizzazione della conferenza di pace di Evian, che ha portato la Francia e l’Algeria al tavolo dei negoziati e ha messo fine a uno dei conflitti coloniali più sanguinosi (1962)
- La mediazione tra la Russia e la Cecenia (1997 e seguenti)
- Il rapporto di indagine sulla guerra tra la Georgia e la Russia del 2008 su incarico del Consiglio dei ministri dell’UE. Il rapporto svizzero è uno dei rari casi in cui un rapporto è stato riconosciuto da entrambe le parti in conflitto.
- Gli accordi di Minsk (2014/2015)
- Le molte iniziative in seno all’OSCE, prima e durante il mandato del segretario generale svizzero, l’ambasciatore Greminger (2017–2020)
Inoltre, Ginevra si è sviluppata come un centro di diplomazia internazionale. La Svizzera è depositaria di circa 80 accordi internazionali, rispetto ai 20 della Germania.
Sono frutto della diplomazia svizzera che viene notata poco o oggi viene minimizzata. Molte iniziative per la pace sono senza dubbio rimaste senza successo. Tuttavia, fare pace è un’arte difficile. Il suo successo dipende dalla volontà delle parti di voler effettivamente stipulare un accordo di pace. E senza una imparzialità credibile da parte dei mediatori, non è possibile. Certo, la Svizzera non è l’unico attore che può condurre negoziati di pace. Ma grazie alla neutralità, finora i rappresentanti svizzeri hanno goduto di una maggiore fiducia rispetto ad altri nel trattare entrambe le parti in conflitto in modo imparziale e uguale.
Tutte queste considerazioni hanno ancora valore in un’epoca di sconvolgimenti geopolitici, in cui con la Cina, l’India, i Paesi BRICS e, in un futuro lontano, anche con l’Africa stanno emergendo nuove aree di potere? Certo, in futuro l’Europa non sarà più il centro del mondo – né economicamente né politicamente. Ma anche la nostra neutralità non può fermarsi ai confini dell’Europa. Deve essere credibile anche per la Cina, per l’India e per tutti i Paesi del Sud globale. E deve inoltre essere credibile anche nei confronti di Paesi con altre religioni o non democratici, nei quali vivono attualmente i due terzi della popolazione mondiale.
In altre parole: in futuro la nostra neutralità deve poter funzionare anche a livello globale.
Naturalmente siamo e rimaniamo europei. Tuttavia, ciò non significa che ci sottometteremo alle pretese di potere dell’alleanza transatlantica e del suo ordine mondiale unipolare. La guida deve essere piuttosto la Carta della pace delle Nazioni Unite, che richiede da tutti gli Stati di rinunciare alla guerra, ma anche alle minacce militari. Se in futuro la Svizzera vuole contribuire alla pace mondiale, deve contrastare le violazioni del diritto di pace dell’ONU, e questo contro le violazioni da ogni parte. Una tale neutralità è una sfida e può essere politicamene scomoda. Tuttavia: i suoi vantaggi economico-politici sono evidenti, ad esempio quando non ci schieriamo da una parte o dall’altra nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina.
Non è affatto egoismo nazionale se una politica commerciale equa considera seriamente anche gli interessi degli Stati non occidentali e dei Paesi in via di sviluppo. Questo serve a bilanciare il mondo povero con quello ricco, senza il quale non può esserci pace duratura in nessuna parte del mondo.
La situazione attuale nel mondo è preoccupante. Tra gli Stati Uniti e la Cina esiste la minaccia di uno scoppio di una guerra commerciale e al momento si procede a un massiccio riarmo in tutto il mondo.
Se il diritto internazionale viene rispettato da uno Stato solo quando gli conviene, ci ritroveremo in un mondo di Stati in cui l’amico di oggi può diventare il nemico di domani. E il mondo probabilmente sarebbe più pacifico se più Stati si sottraessero all’influenza delle grandi potenze.
Ecco perché: la neutralità ha un futuro!
La neutralità svizzera e il suo impegno per le solide basi del diritto internazionale non servono solo alla propria sicurezza e alla pace interna nel Paese. Possono inoltre fornire un modesto contributo a un mondo più pacifico.